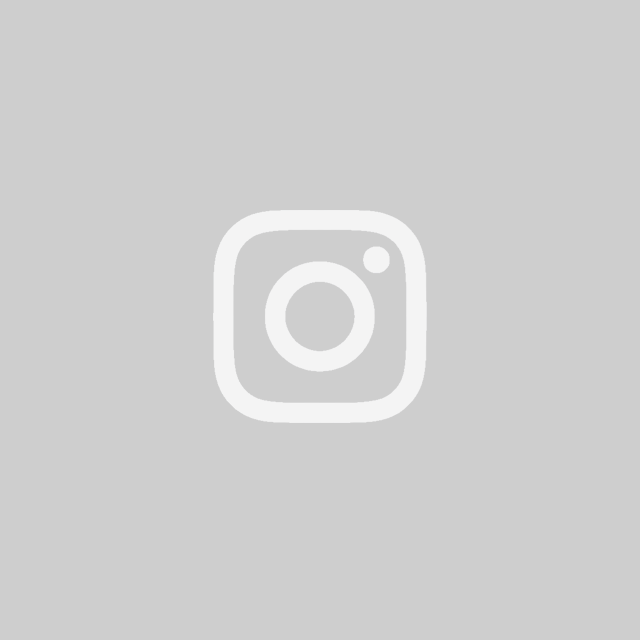Il racconto di Matilde Serao sull’Assunta a Santa Maria CV
NON PIÙ!
La piazza del Mercato, grandissima, riboccava di gente. La folla si accalcava non solo nel suo vasto quadrilatero, addossandosi alle baracche dei saltimbanchi, alle tende ambulanti dei venditori di sorbetti, al piccolo carosello giallo e rosso; ma si addensava lungo il Corso Garibaldi, verso l’Anfiteatro e verso il tribunale, straripava su molti balconi e su tutte le terrazze prospicenti nella piazza. Non erano soltanto i ventimila abitanti di Santa Maria che avevano lasciato le loro case, in quella sera di mezz’agosto, per assistere al grande fuoco d’artifizio in onore dell’Assunzione di Maria Vergine: ma anche dai villaggi e dalle città vicine erano accorsi, per devozione e per curiosità. Nella folla minuta si mescolavano ai samaritani conciatori di cuoio, gli ortolani di San Nicola la Strada, i setaiuoli di San Leucio, i fabbricanti di torroni di Casapulla, gli agricoltori di Maddaloni e di Aversa, le pallide maceratrici della canape che languiscono una intiera stagione sulle sponde dei lagni: sui balconi illuminati a palloncini colorati, la borghesia e l’aristocrazia samaritana facevano gli onori dell’Assunzione alla borghesia e all’aristocrazia di Caserta e di Capua.
Sulla terrazzina del Circolo Militare che aveva dei festoni di lanterne chinesi, Giorgio Lamarra, il bello e biondo tenente di artiglieria, sospiro delle romantiche fanciulle samaritane, faceva il chiasso, con un gruppo di ufficiali di Nizza cavalleria, venuti da Capua: dal balconcino di sua zia, Clementina Riccio, la brunetta languida e malinconica, non cessava di guardare il terrazzino e Giorgio Lamarra: dal balcone della sua comare, donna Peppina Cannavale, Paolina Gasbarra, la loschetta vivace e spiritosa, si piegava sullo sporto e rideva ad alta voce per farsi udire da Giorgio Lamarra: da uno dei cinque balconi di Rosina Sticco, la novella sposa, riboccanti di luce e di persone, Grazia Orlando, la più bella creatura di Santa Maria, fingeva di discorrere con la sua cugina di Napoli, Caterina Borrelli, ma in realtà teneva d’occhio il terrazzino e Giorgio Lamarra — nessuno di loro aveva uno sguardo per le otto macchine pirotecniche, allineate sul lato destro della piazza, e per il castello, il pezzo finale dove si doveva vedere il trionfo della Madonna, Assunta in cielo.
Sul balcone grande del municipio, le due ragazze Roccatagliata, le figliuole del sindaco, due gentiline sottili e brune, si affaccendavano intorno alle tre sorelle Capitella, figliuole del sindaco di Caserta, venute nel loro equipaggio scortate dal padre e dal fratello, che doveva sposare Cristina Roccatagliata: matrimonio che a tutte le ragazze coetanee di Cristina, diciottenni, pareva logico, e che tutte le ragazze fra i ventitrè e i venticinque, fra cui Emma Demartino, dicevano irregolare: Cristina era troppo giovane. Le tre sorelle Capitella avevano ciascheduna centocinquantamila lire di dote; le due Roccatagliata centomila lire; Clelia Mesolella, sposa di un anno, ne aveva portato duecentomila; Felicetta de Clemente aveva trovato mezzo milione in casa del giovane marito, talchè il balcone del municipio il più ricco come doti passate, presenti e future, era l’oggetto di molti sospiri maschili e femminili. Le due spose Clelia e Felicetta scintillavano di gioielli.
Anche il balcone del marchese Tarcagnota esponeva tre grandi doti di centocinquantamila lire, nelle persone delle tre sorelle Tarcagnota, ragazze, uscite dal primo educandato di Napoli, aristocratiche, superbe; ma le tre ragazze erano afflitte da una tale pinguedine enorme e crescente, quella grossezza loro era così soffocante e ridicola, che tutti i belli spiriti di Santa Maria se ne burlavano. Quella sera esse erano tutte orgogliose di poter ricevere la vecchia duchessa di San Demetrio, che era venuta dal suo castello di Recale, e il loro balcone brillava nobilmente di dodici lumi a moderatore. Ogni tanto, in quel chiarore, un fagotto si profilava, una guancia grossa, quasi gonfia si delineava, una curva possente di spalla si arrotondava, un braccio corto, grosso che pareva dover far schiantare la manica, si agitava: era una delle ragazze Tarcagnota che si moveva.
Ma il gran movimento era sui cinque balconi di Rosina Sticco, la novella sposa: Rosina, la primogenita delle sette sorelle Astianese, si era maritata la settimana prima con Vincenzo Sticco, negoziante ai cereali, gli aveva portato cinquantamila lire: il papà Astianese era molto ricco, ma aveva sette figliuole, da dodici a venticinque anni. Sticco era il più ricco del paese, aveva la più bella casa con cinque balconi sulla piazza, l’aveva fatta mobiliare da un tappezziere di Napoli, e Rosina faceva, con un legittimo orgoglio, per la prima volta, gli onori della sua casa. Portava le grosse rosette di brillanti datele dal marito, otto o dieci braccialetti pesanti e luccicanti, ed era soddisfatta di sè, del suo salone rosso e oro, della sua stanza da letto azzurra e bianca. Ella mostrava tutta questa roba, a tutti e a tutte, senza celare la sua soddisfazione.
La casa era piena di ragazze e di spose. Prima le sei sorelle Astianese, in scalatura, brune, bionde, fulve, di tutti i gusti, di tutte le stature, sbucanti da tutte le parti, tanto che parevano dodici, aventi ognuna il suo pretendente in piazza, o su qualche balcone, o alle finestre del Circolo Garibaldi: poi Grazia e Maria Orlando con la cuginetta di Napoli, Caterina Borrelli; poi Lucrezia Piccirillo Sticco, la cognata di Rosina, maritata a un proprietario di Casapulla; poi Luisa Ciccarelli, la più brutta ragazza del paese, inebetita dalla sua bruttezza, con la bocca sempre un po’ schiusa e le grosse mani penzoloni; poi Carmela Barbaro, la giovane sposa del cancelliere, venuta da un villaggio albanese della Calabria, mezza orientale, mezza montanara, che era bruna bruna, fumava sempre e parlava pochissimo; infine la grande amica di Rosina, la sua coetanea, Emma Demartino, la pallidina alta e gentile, un po’ anemica, la ragazza sentimentale dagli occhioni un po’ bruni e dalla testina languente.
Come arrivava gente, Rosina Sticco si faceva sempre più serena, affettuosa, nella bonarietà naturale e pacata delle giovani spose; come arrivava gente, ella chiamava suo marito, con maggior dolcezza:
— Vincenzino? Vicenzì?
Le ragazze, in su e in giù dai balconi al salone, all’anticamera, alla stanza da letto, guardavano tutto curiosamente, con un sorriso enigmatico, leggermente turbato da quell’ambiente matrimoniale che era la realtà de’ loro sogni. Certo non vi erano sei giovanotti, come Vincenzino Sticco dentro Santa Maria: ma le sei sorelle Astianese erano sicure di maritarsi meglio della prima: Emilia sognava di stabilirsi a Napoli, ella era ambiziosa, audace, rinunziava alle rosette e ai braccialetti di brillanti, ma voleva andare a Napoli; Grazia Orlando, che aveva per lo appunto ventimila lire, la dote militare, pensava al suo bell’ufficiale biondo, dalla sciabola scricchiolante, tanto più bello di Vincenzino Sticco; Maria Orlando, più calma, meno sognatrice, calcolava che avrebbe avuto di sua parte Ciccillo Mosca, il primo dei tre fratelli Mosca, che, ogni tanto, nei caldi pomeriggi, veniva a passare sotto le sue finestre, alla Croce; Caterina Borrelli, troppo giovane ancora, aveva già l’aria disinvolta e presuntuosa delle ragazze napoletane, che fingono di burlarsi del matrimonio; Luisa Ciccarelli, la stupidona, tastava le stoffe per sentire se erano di seta, pensava se il merletto delle cortine si poteva imitare all’uncinetto, leggeva i biglietti da visita giunti per le congratulazioni, incretinita, senza idee, senza sogni. Emma Demartino, la migliore amica, la coetanea di Rosina, la seguiva dappertutto dove ella andava, come trasognata, e quando Rosina, con la sua voce armonica e raddolcita diceva: “Vicenzino? dove sta Vincenzino?” Emma provava una emozione, come uno struggimento di tenerezza.
A un tratto, un grande chiarore attirò ai balconi tutti e tutte: ma era un falso allarme, al Circolo militare accendevano dei fuochi di bengala, Giorgio Lamarra ne braccia tese, ed era illuminato fantasticamente di rosso. Clementina Riccio, dal suo balcone, agitava il fazzoletto, come per farsi vento; Paolina Gasbarra, la briosa loschetta, gridava bravo, bravo, senza potersi più contenere — e Grazia Orlando era tutta commossa, a vedere il suo bell’ufficiale in tutta quella luce rossa, come Fausto o Mefistofele. A quel chiarore si vide bene che sui balconi del municipio si
portavano in giro le granite, le ragazze Roccatagliata andavano e venivano, offrendole agli invitati: mentre, attirate dalla luce, credendo che il fuoco artificiale cominciasse, si erano financo schiuse le finestre di casa Crocco. Le due Crocco, brune scarne, tutte chincaglierie, tutte spilloni di acciaio e fibbie di pastiglia, si affacciarono, mostrando il loro volto arrabbiato di zitellone, ostinate nel desiderio del marito: le due Caputo, amiche fedeli, si affacciarono anch’esse, pettinate e vestite alla moda di quindici anni prima, ma tutte tranquille e ridenti, sopportando pazientemente i quarant’anni della loro disponibilità, e infine si affacciò donna Irene Moscarella, la zitellona preistorica, quella che tutti ricordano zitellona, da un tempo immemorabile, la zitellona non più collerica nè ridente, ma quietata nell’apatia, nella quasi immobilità della vita.
Emma Demartino era rimasta sul balcone, pensando, mentre due bande musicali, una a destra, l’altra a sinistra, suonavano ora la marcia reale, ora l’inno di Garibaldi. Era felice, molto felice per Rosina, la sua amica, ma pensava che se Carluccio Scoppa, che studiava a Napoli l’avvocatura, non si fosse fatto bocciare in due materie lei, Emma, si sarebbe maritata prima di Rosina: Carluccio era a Napoli, a prepararsi per gli esami di riparazione, a novembre sarebbe riuscito ad aver la laurea e forse per l’altro agosto si sarebbero sposati. Che peccato, dover perdere così un anno! Lei ne aveva già venticinque, è vero, e questo le dava come un pensiero latente di malinconia, come una punta di amarezza: si sentiva pallida, smorta, sfiorita, mentre i venticinque anni di Rosina Sticco erano tutta una fioritura di rosei colori e di sorrisi. Con quanta grazia Rosina andava intorno, offrendo confetti e vino di Marsala, lieta dei suoi larghi vassoi d’argento, dei suoi bicchierini di Boemia, dei dolci che erano venuti da Napoli, e del vino che Vincenzino aveva fatto venire dalla Sicilia! Se Carluccio avesse avuto miglior sorte agli esami! Ora sarebbe lei, Emma, che regalerebbe alle sue amiche i confetti del matrimonio. E non volle mangiare quelli che Rosina le offrì. Una grande malinconia le era piombata sull’anima.
Intanto, un sparo di mortaletti annunziò che lo spettacolo cominciava: una delle macchine principiò ad ardere, a tre colori, a girandole roteanti, a razzi. Il popolo samaritano applaudì, la folla ondeggiò tutta, per la soddisfazione. Emma si scosse, scrollò le spalle, cercò liberarsi dalla malinconia: in fin de’ conti non era la più infelice di tutte. Quelle sorelle Astianese avevano, è vero, cinquantamila lire di dote, ma erano sei, un reggimento, un corpo di esercito, facevano sgomento ai giovinotti, chi sa se si sarebbero maritate? E le tre innamorate di Giorgio Lamarra erano tre sciocche: nè Clementina Riccio, nè Paolina Gasbarra avevano la dote militare, e il padre di Grazia Orlando non l’avrebbe mai data a un ufficiale — e lui, Giorgio, le ingannava tutte tre, aveva una innamorata a Firenze, tutti lo sapevano, non avrebbe sposata che quella.
Ardevano allegramente le girandole tricolori, sprizzando scintille, mentre i contadini di Altifreda, delle Curti, di Centurano e di Cancello Arnone guardavano a bocca aperta; ardevano i cuori delle ragazze Astianese e delle tre innamorate di Don Giovanni, ma che restava? Un po’ di fumo, una grande ombra, un barbaglio doloroso negli occhi.
Ma subito un’altra macchina s’accese, era una scappata di razzi che salivano altissimi nel cielo, si schiudevano lassù, con una debole detonazione, come un fiore che si apre, e si dividevano in tante stelle di colori delicati. Le ragazze Capitella erano molto ricche, ma per questo nessuno osava ricercarle: le loro pretensioni erano stravaganti, nella provincia non vi era nessuno che potesse contentarle: si sarebbero le Capitella maritate? E anche la Roccatagliata, la minore, faceva male a maritarsi prima della maggiore: ciò è di cattivo augurio, in provincia ci si bada bene. In quanto alle Tarcagnota, a malgrado dei loro quattrini, esse erano troppo grasse, non si potevano maritare: Luisa Ciccarelli era troppo brutta, troppo imbecille. A malgrado dei delicati razzi che si aprivano in cielo dolcemente, in quella mite sera di agosto, a malgrado dell’estasi di quella folla istupidita dai chiarori, a malgrado dell’allegrezza di tutta quella gioventù maschile e femminile, sparsa pei balconi, Emma si sentì inondata di amarezza, la vita per lei, per le altre le parve un lungo cammino senza gioie, un duro cammino senza compensi e senza soccorsi.
Gli è che sotto il grande chiarore giallo di una pioggia d’oro che zampillava come da una fontana di fuoco, le due finestre di casa Crocco facevano pompa della loro mostra di vecchie zitelle. Le due Crocco agitavano le teste lucide di pomata e infiocchettate, si curvavano per vedere se veramente nel salone da pranzo delle Tarcagnota era preparata una grande cena, mostravano le dentiere ingiallite, con una smorfia che doveva essere, a parer loro, un sorriso d’ironia; le due Caputo coi capelli abbassati in due falde sulle tempie, i busti lunghi e piatti, i grembiuli di seta nera, ammiravano almeno per la quarantesima volta, la festa dell’Assunta, e sorridevano mitemente, mentre donna Irene Moscarella, vestita di lana color pulce, coi radi capelli raccolti in rotoletti sulle tempie, serbava la sua faccia scialba e senza espressione, la sua aria indifferente, di persona morta a tutte le cose umane.
Emma vedeva queste cinque femmine tutte smorte o livide sotto la grande pioggia d’oro del fuoco di artifizio, e le sembrava scorgere in quel gruppo tutta una visione dell’avvenire, le pareva che lei e tutte le sue amiche dovessero invecchiare zitelle, diventare rabbiose e cattive come le due sorelle Crocco, placidamente rassegnate come le due sorelle Caputo, o indifferenti come donna Irene Moscarella. Ecco, forse a una di loro sarebbe morto il fidanzato come a Chiara Caputo, due giorni prima del matrimonio; ad un’altra sarebbe toccato di esser tradita come Marietta Caputo: qualcun’altra sarebbe rimasta zitella per la tremenda avarizia del padre, come Margherita Crocco: qualcuna non si sarebbe maritata per un accesso temporaneo di misticismo come Vincenzella Crocco, e un’altra, chi sa, forse lei, Emma Demartino, sarebbe rimasta zitella, non si sa come, non si sa perchè, per capriccio della sorte, come donna Irene Moscarella. E fu tanta la forza dell’evocazione, che ella si vide, già arrivata a cinquantacinque anni, vestita di lana color pulce, coi capelli radi che non coprivano più il giallo della cute, con la faccia scialba e rugosa, dove niuna impressione più si rifletteva, in quel distacco egoistico e supremo di tutte le cose.
Ma dopo avere applaudita la fontana di fuoco si fece nella folla un grandissimo silenzio. L’ultimo pezzo cominciava. Era prima un grande arco di trionfo, tutto lampioncini colorati che portava scritto nel frontone Viva Maria, poi quattro pezzi di fuochi d’artifizio, in quadrilatero, a mazzo di fiori, a scappate di razzi, a girandole, a girandolini. Come l’arco fu tutto quanto illuminato, nel vano profondo, con la testa verso il cielo, con le bianche mani schiuse e distese che pareva salutassero la terra, la statua della Madonna cominciò ad elevarsi. Saliva lenta lenta, come librantesi, e i potenti argani con cui era tirata su, non si vedevano. Era vestita con la tunica rossa, col manto azzurro, e sorrideva al cielo e dava l’addio alla terra. Le campane della cattedrale, di San Carlo, della Croce, di Sant’Antonio suonavano a gloria. Ardevano i fuochi incandescenti, gittando fiamme, sprizzando scintille, vomitando stelle: molti balconi avevano accesi i bengala. Nella piazza il popolo era inginocchiato, pregando, acclamando la Bella Mamma Assunta in cielo.
— Nelle vostre mani, Vergine Santa — pregava Emma, sul balcone — nelle vostre mani, io, e tutte quante.
La puerpera appoggiava il capo e le spalle a un grande mucchio di cuscini, dalle foderette di tela finissime tutte adornate di ricami: le due mani bianchissime, esangui, si allungavano sulla larga trina antica, che formava la rimboccatura del lenzuolo e toccavano quasi il damasco azzurro della coperta. Ella portava una camiciuola di batista tutta spumosa di merletti; sui capelli bruni, ondulati, una cuffietta di gala; e le dita, i polsi, le orecchie erano ornate di molte gemme. Ella poco si muoveva, poco parlava, un po’ pallida, ma beatamente sorridente: ogni tanto socchiudeva gli occhi, come se si addormentasse.
Dalla mattina la casa era piena di gente che andava e veniva, ella era stordita da tante domande, da tante congratulazioni: alla fine, verso le due, ella aveva dato un bacio al suo bambino che le avevano portato in abito da battesimo, e tutti erano andati alla cattedrale: ella respirava, tranquilla, riposandosi, poichè fra poco l’andirivieni sarebbe ricominciato. Emma, seduta a’ piedi del letto, le parlava, sottovoce: ella non aveva voluto andare alla chiesa.
— Rosì, perchè chiamarlo Gaetano?
— Così ha voluto Vincenzino — fece la puerpera, movendo un sol dito, per esprimere che non vi era da opporsi.
— È un brutto nome.
— Brutto: ma la creaturina è bella.
— Tutti i figli tuoi sono belli — mormorò Emma.
— Questo è il più bello — disse la madre, placidamente.
— Quando avrai il quinto, dirai che quello è il più bello.
— Già — acconsentì la puerpera sorridendo.
Vi fu un momento di silenzio. Rosina Sticco odorava una ciocchetta di erba, l’erba cara alle
donne partorienti. Emma passava leggermente le dita sul damasco della coperta, come se lo carezzasse: e gli occhioni bruni erano più che mai nuotanti nel languore, il pallore di creatura anemica si tingeva di un lievissimo giallo, ancora impercettibile.
— Tua sorella Giannetta non è venuta da Caserta? — chiese Emma.
— No, poverina: ha la suocera malata. Maria mi ha telegrafato da Piedimonte e Costanza mi ha scritto da Verona.
— Costanza ha due figliuoli? — Due.
— E Maria?
— Uno: e uno Giannetta.
— E tu quattro: la mamma tua è già otto volte nonna.
— Otto: ma ha ancora tre figlie da maritare. Non dico per Olimpia e per Teresa: ma Assunta ha già ventotto anni, mi fa pena, capirai….
Un lieve rossore salì alla fronte di Emma.
— Che importa? mormorò costei. — Non ci è obbligo di maritarsi.
— Non lo dire, cara. Qualunque cattivo matrimonio, val sempre meglio di nulla.
— E perchè?
— Per i figli, Emma — disse gravemente e dolcemente la madre felice.
Un velo di lagrime tremolò per un minuto negli occhi di Emma.
— I figli…. i figli — disse lei. — Che ne farai di questi bei figliuoli?
— Per ora, me li godo io…. sono così piccolini! Ma Vincenzino è pieno di ambizione per loro. — Parlate sempre dei bimbi, fra voi.
— Sempre.
— E l’avvenire ti piace?
— Non è il mio che m’interessa, è il loro.
— È vero — soggiunse Emma.
Di nuovo tacquero.
— Quanto tardano — mormorò la puerpera. — Avranno fatto il giro largo: o la mamma li avrà
trattenuti.
— La matrina è Grazia?
— Sì, Grazia Orlando: e suo marito, il padrino.
— Ti rammenti, Rosina? Pareva che impazzisse per Giorgio Lamarra, Grazia: e poi è guarita,
ha sposato l’avvocato Santangelo.
— Ha fatto bene: a che amare un birbante come quello?
— Anche Clementina Riccio, si è consolata e ha sposato suo cugino, lo zoppo…. che bella
costanza!
— A che servono questi amori così lunghi, Emma?
— Quando si vuol bene, chi si accorge del tempo?
— Con Vincenzino ci siamo sposati dopo sei mesi di amore.
— Ma di Vincenzino ce n’era uno solo, il tuo; e la intonazione era fra dispettosa e umile.
Una viva pietà si delineò sul volto della malata. Ma non ebbe tempo di dire una dolce parola a Emma. Caterina Tarcagnota, maritata Savarese, entrava, enorme in un vestito di stoffa nera, con le guancie rosse e lucide, con le braccia simili a colossali salsiccioni. E subito, con un sospiro, esclamò:
— Oh cara signora Sticco, a chi tanto, a chi niente!
— Avete il tempo, cara baronessa, ne farete dodici.
— Possa passare un angelo e dire amen; ma io ci spero poco, tutto dipende dalla complessione. — Così si dice, ma chi lo sa? la Roccatagliata, così magra, ne ha forse fatti?
E mentre così discorrevano, altre signore sopraggiunsero, per la visita di prammatica. Clelia
Mesolella con un vestito nuovo e un paio di nuovi orecchini, due grossi smeraldi; Felicetta de Clemente incinta di cinque mesi; Carmela Barbaro a cui l’aria bassa di Santa Maria aveva illanguidito sempre più gli occhi orientali; Lucrezia Sticco-Piccirillo che era venuta apposta da Casapulla: sedute in circolo, attorno al letto, parlando a voce discreta, esse s’intrattenevano di figliuoli, di gravidanza, di casi orrendi e di casi strani, di voglie, di odori, di chirurghi e di levatrici.
Tutte mostravano il più grande interesse a sapere da Rosina, come era andata la cosa: ed ella rifaceva il breve racconto, non aveva sofferto punto, tutto benissimo, il bel maschio aveva fretta di nascere. E le ascoltanti scrollavano il capo, soddisfatte, sorridenti, e l’una dopo l’altra, rinviandosi delicatamente il discorso, narravano ognuna il loro piccolo aneddoto di maternità, e intanto le altre prestavano un’attenzione cortesissima, seguendo tutte le peripezie, facendo qualche breve esclamazione. A qualche asserzione, tutte facevan coro: oppure qualcuna contraddiceva, un’amabile discussione sorgeva.
L’ambiente si empiva di queste voci intenerite, di questi discorsi dolci e gravi, in apparenza frivoli, ma in cui si riassume tutta la vita femminile: queste spose che erano già madri, o dovevano esserlo, o desideravano profondamente di diventarlo, si lasciavano andare a tutto l’affettuoso che sgorgava, naturale, dal cuore aperto.
Rosina ascoltava, già rosea, approvando col capo o negando con un cenno della mano, ella, la madre felice. Ritta, immobile, appoggiata alla spalliera del letto, Emma, la sola fanciulla in quella stanza, ascoltava. Tutta quella maternità che fluiva nelle parole, nei sorrisi, nelle voci, negli sguardi, in certe intonazioni, tutta quell’onda letificante di amore, arrivava sino a lei, penetrandole nell’anima, ella beveva quasi, tutta quella dolcezza: e nello spasimo di quella impressione troppo acuta, il viso pallido diventava cereo, e i grandi occhi languidi si facevano più tristi, più trasognati che mai.
Dalla strada salì un rumore sordo di ruote: la puerpera si distrasse, chinò le palpebre, restò come assorbita: le signore tacquero, aspettando. Una viva scampanellata, risuonò per tutta la casa; il volto della puerpera si tramutò. E in anticamera sorse un vocio intenerito di serve, di familiari:
— È tornato, è tornato! San Gaetano lo benedica! Cresci santo, cresci santo!
Il piccolo essere si avanzava, portato solennemente sulle braccia di Grazia Santangelo Orlando: il lungo abito bianco da battesimo, tutto merletti, tutto ricami, pendeva da un lato, la testina si appoggiava sopra un cuscino, tutto a merletti. La faccia un po’ rossa, dalla pelle delicata, s’incorniciava fra l’arricciatura di una cuffietta di gala: gli occhietti aperti avevano lo sguardo serio serio dei neonati: la bocca si schiudeva ogni tanto, con quel moto adorabile degli uccelletti che vogliono beccare; e una manuccia piccolina piccolina agitava lievamente le dita, come se già il neonato pensasse dentro di sè. Grazia Orlando Santangelo, con un vestito venuto apposta da Napoli, di broccato, con un cappello scintillante di perline, tutta dignitosa, attentissima, tendeva le braccia, portando il piccolo come sopra un vassoio. Dietro di lei la levatrice, donna Mimma Scaletta, sfoggiava un abito di seta verde pisello, uno scialle di crespo bianco, un cappello nero carico di rose rosse, uno spillo di mosaico che rappresentava il Colosseo di Roma: e aveva la grassezza tradizionale di tutte le levatrici, l’aria d’indulgenza bonaria, la gravità della persona importante. Venivano dopo Viucenzino Sticco, il padre fortunato, e Ciccillo Santangelo, il compare, in marsina e cravatta bianca: e tutta la processione delle vecchie zie, la signora Astianese con le tre figliuole ancora zitelle; Emma, Ferdinando e Carluccio, i tre figliuoli di Rosina.
Un grande cerchio di persone ritte si formò attorno al letto, e in quel vuoto, Grazia Santangelo si avvicinò alla puerpera: con voce un po’ tremante, offrendole il bambino, le disse:
— Comare mia, ti riporto un piccolo cristiano.
La madre prese il piccolo cristiano nelle braccia, si chinò su lui e lo baciò, a lungo. Forse, tacitamente, gli diceva qualche cosa: forse, sul piccolo cristiano, scendeva la fervida benedizione materna, viatico d’amore per tutta l’esistenza. Un silenzio profondo, pieno di emozione, regnava nella camera: Grazia Santangelo fermava un braccialetto di perle e smeraldi al polso di Rosina, il dono della comare; Ciccillo Santangelo aveva posato sul letto un astuccio di cuoio rosso, dove era riposta una posatina di argento e un bicchiere, il dono del compare al bambino. Poi Rosina diede di nuovo il piccolo cristiano a Grazia, le due donne si baciarono, e sulle braccia di Grazia il piccolino andò in giro.
Fu portato prima al bacio del padre, Vincenzino Sticco, che osò appena sfiorargli la guancia, per paura che il mustacchio grosso lo facesse piangere; poi a quello della nonna, che gli fece un segno di croce sulla fronte e sul petto; poi alle ragazze Astianese, le giovani zie, poi, in giro, a tutte le signore. La puerpera seguiva questa presentazione con lo sguardo, sorridendo un poco, e abbassando il capo, quasi ringraziando, a ogni frase di tenerezza, che tutte quelle persone rivolgevano al cristianello. Ed era un concerto: il piccolo con la faccina minuta, col nasetto abbozzato, con quella smorfietta della bocca, con quella molle peluria bionda che spuntava di sotto la cuffietta, sulla fronte, con quella delicatezza di ditini irrequieti, inteneriva tutta la società. Lo baciavano pian piano, per non fargli male, per non farlo piangere, gli dicevano delle paroline di amore, quei piccoli nomi che il cuore femminile inventa: le ragazze lo guardavano curiosamente come un oggettino raro.
Tommaso, il servitore, andava intorno, con vino e dolci: offrivano, per giuoco, dei confetti al cristianello serio serio, e il compare Santangelo voleva fargli bere del Marsala, per avvezzarlo presto, diceva. E degli scherzetti provinciali corsero, sul Marsala che preferiscono i cristianelli: mentre la nutrice, Olimpia, una contadina di Cascano, stava ritta in un angolo, bellissima sotto il fazzolettino di batista bianca, appuntato sul capo da grossi spilloni, con la gonna di seta violetta cangiante, il guarnello di seta gialla e il busto di seta nera gallonato d’oro.
Infine venne la volta dei bimbi: Emma e Ferdinando avevano seguito passo passo Grazia Santangelo che portava sulle braccia il loro fratelluccio, Emma toccava ogni tanto il vestito da battesimo, Ferdinando si rizzava sulla punta dei piedi ma non riusciva a veder nulla, Carluccio si attaccava a Ferdinando, avendo due anni, portando ancora la gonnelluccia da donna. Quando tutti ebbero baciato il piccino, Grazia Santangelo sedette, e i tre bimbi, soddisfatti, la circondarono. Stava in mezzo il cristianello, con gli occhietti spalancati e la boccuccia che sbadigliava, i tre bimbi si guardavano in silenzio. Emma soltanto, la donnina lo baciò: Ferdinando gli mise un braccio attorno alla testa, sul cuscino. E come la manina del cristianello si agitava, Carluccio gli dette un ditino: e la manuccia del neonato si strinse attorno a quel ditino.
…………………………………. ………………………………….
Cadevano le ombre crepuscolari in quella camera. La puerpera, stanca, appoggiava il capo ai cuscini e socchiudeva gli occhi, come per dormire. La stanza era vuota. Ella si voltò, cercò con la mano accanto a lei, e con fievole dolcissima voce materna, chiamò:
— Gaetanino? Gaetanì?
Il piccolino guardava la mamma, con gli occhietti vivaci. Ma dietro una tenda, un piccolo singhiozzo s’intese: Emma Demartino singhiozzava.
III.
Ella misurò il lavoro fatto con l’occhio esperimentato, e vide che la calza arrivava ormai alla fine del polpaccio: bisognava cominciare una serie di maglie doppie per diminuire il giro della calza intorno al collo del piede. Attentamente, con l’unghia del pollice che strisciava sui ferri, essa contava le maglie; quando nell’aria cheta pomeridiana, nel grande silenzio estivo provinciale, un fischio dolcissimo risuonò. Subito, Emma levò gli occhi e guardò fra le stecche della persiana verde: Federico Mastrocola era al suo posto, alla piccola finestra del granaio, mostrando la testa bruna tutta arruffata di ricci, e torcendosi il mustacchietto incipiente. Emma chinò di nuovo gli occhi e ricominciò a fare il conto delle maglie che doveva diminuire: nel suo volto pallido di fanciulla anemica si era manifestato, con gli anni, un crescente scolorimento.
Gli occhi avevano perduto e la vivacità e il languore che li rendevano tanto seducenti, erano diventati come smorti, come opachi; due borse di pelle floscia, giallastra, con qualche intonazione livida si erano formate sotto le palpebre; le labbra erano passate dal rosso al rosa, dal rosa al violetto pallidissimo, delicato. Ancora le guancie conservavano una finezza elegante e la carnagione sulle tempie, intorno alle orecchie era bianca e trasparente come la porcellana; ma quello che invecchiava quel volto, senza rimedio, non era la radezza dei capelli male dissimulata, non era la magrezza del collo; erano quelle due borse di pelle floscia, come morte, già tinte dei colori della corruzione e della decomposizione. Le mani che lavoravano alla calza conservavano la loro bellezza, ma già i polsi avevano certe sottili rughe, che ne aggrinzivano la pelle; la cintura era ancora sottile, ma un segno infallibile della vecchiaia era il taglio dell’abito, molle e piatto sul petto, corto di vita, largo sui fianchi, quel taglio tutto fantastico ma tutto speciale della vecchia zitella; il segno della vecchiaia era in quelle scarpette di marocchino nero, quadrate in punta, annodate coi nastri di seta nera, col tacco largo e basso, che non facevano rumore nel camminare.
Di nuovo, il fischio di Federico Mastrocola risuonò, dolcissimo: uno zufolìo gli rispose: alla loggetta di Chiarina Oliver, una personcina bionda era comparsa, tutta inondata di sole, ammiccando con gli occhi azzurri: era Emma Sticco che tutti chiamavano Mimì per la sua gentile bellezza. Dietro a, lei, Chiarina Oliver s’intravedeva seduta, china sul suo lavoro all’uncinetto, una grande coperta fatta tutta di stelle; la si vedeva, occupata solo dal suo lavoro, disinteressata da quello che poteva fare fuori della loggetta Mimì Sticco, la sua amica. Veramente anche la biondina Mimì teneva in mano una stella all’uncinetto: ma non lavorava, sorridendo a Federico Mastrocola. La distanza fra la loggetta di Mimì e il granaio di Federico era poca: ambedue sporgendo nel grande orto d’Oliver, tutto verde di alberi di fichi; accanto vi era l’orto delle Tarcagnota, ma le altre due grassone si erano maritate, una a Nola, un’altra a Napoli; la primogenita era morta di parto, tutte le finestre erano sbarrate; sicchè restava solo il balcone di Emma Demartino donde si poteva vedere l’armeggio dei due innamorati. Ma la persiana verde non si rialzava mai, la vecchia zitella non si mostrava mai, restava dietro le stecche a lavorare la calza. E in quella calda pace del pomeriggio estiva, in quel silenzio di provincia dormiente che digerisce i maccheroni, i due innamorati chiacchieravano, sotto la tutela amichevole di Chiarina Oliver, che fingeva di non udire.
— Perchè non sei venuto alla messa, stamattina? — disse la biondina, cercando invano di prendere un’aria severa, mentre gli occhi le brillavano di amore.
— Ho dovuto accompagnare alla stazione le zie Caputo.
— Sono partite?
— Sì: a quest’ora sono già nel ritiro di Mondragone.
— Mi ci voglio ritirare anch’io, Federì, — esclamò, ridendo quella gentile.
— Aspetta di avere sessantacinque anni, Mimì, e di non aver più un cane che ti voglia bene.
Per un momento le mani di Emma Demartino, zitellona, si fermarono sui ferri come
immobilizzate. Poi si passò una mano sulla fronte, quasi a diradarne una nube: fredda la mano, freddissima la fronte.
— Dopo la stazione, dove sei stato? — ricominciò la bionda e terribile inquisitrice. — Ti ho cercata in piazza.
— Non è vero niente.
— Te lo assicuro.
— Non è vero: non dire una bugia.
— Domanda piuttosto a Luisa Ciccarelli e a suo marito: sono stato con loro.
— Domanderò: ho visto Luisa alla messa, avea un cappello rosso che le stava malissimo, era
gialla, era orrenda.
— Era orrenda: ma il cappello era verde e la faccia era color terra, — esclamò l’innamorato con
voce trionfante, non essendosi lasciato cogliere in trappola.
Rideva Mimì Sticco, la furba che aveva teso il tranelluccio, dove Federico non era cascato;
rideva anche, sottovoce, Chiarina Oliver: ma dietro le stecche verdi nessun sorriso sfiorava le labbra violette di Emma. Ella badava che le maglie doppie fossero a destra e a sinistra della bacchetta, tutte eguali in modo che la calza discendesse bene sino al tallone. Udiva tutto il discorso dei due giovanetti, lo udiva quel giorno, come da due mesi, sopra i melagrani fioriti dell’orto Tarcagnota, sopra la verdura larga e fitta dei fichi dell’orto Oliver: e al chiacchiericcio ora allegro, ora sentimentale dei due innamorati, si accompagnava lo stridìo di certe cicale; e il ponente portava talvolta un cattivo odore di cuoio conciato o di canapa in macerazione, talvolta strappava dei profumi all’orto Astianese, dove erano fioriti i mandarini. Ma nulla sapevano, Mimì la bionda e Federico, di quanto accadeva intorno a loro, puzzo o profumo, canto di cicale o ronzìo greve di mosconi: nulla sapevano di quello che avvenisse dietro la persiana verde.
— O Mimì, con chi sei andata alla messa?
— Con mammà e zia Lucrezia Piccirillo.
— È vero che ti vogliono far sposare Antonio Piccirillo?
— Ho pregato santa Emma, stamane, perchè questo non sia.
— Santa Emma vorrà proteggerci, Mimì?
— Così speriamo, — mormorò la biondina, congiungendo le mani.
— Speriamo, — soggiunse Federico, diventato pensoso.
Dietro la persiana, la zitellona guardava le maglie bianche della sua calza, ma non le vedeva:
col quarto ferro, distrattamente, si punzecchiava una guancia. Sotto l’urto del ferro la pelle floscia cedeva; ma non si scorgeva una goccia di sangue, dietro quella carne appassita di creatura anemica. Ripensando alle parole di speranza che i due giovani avevano pronunziate, ella chinava il capo sotto i ricordi delle speranze morte, tormentando la sua guancia esangue, stuzzicando il suo cuore silenzioso e secco.
— Ma esiste una santa Emma? — domandò Federico, volendo fare pompa di scetticismo. — Sei un eretico, Federico, — osservò gravemente Mimì Sticco.
— Nel calendario non c’è.
— Leggi il calendario francese; leggi il martirologio; vedrai se c’è.
— Se manca la santa, santificheranno te, Mimì.
— Certamente, per la pazienza che ho con te.
L’idillio per un poco diventò drammatico. La biondina era furiosa, perchè Federico non avea
un’oncia di serietà, scherzava su tutto, non si poteva esser sicuri di nulla con lui; Federico, irritato, scrostava dei pezzi d’intonaco e li scagliava sulle lucertole dell’orto Oliver, ferocemente. Chiarina Oliver dovette interporvisi; a una certa ora della giornata, doveva sempre intervenire fra i due innamorati.
— Che vi hanno fatto le lucertole, Federico? — domandò Chiarina, ridendo. — Nulla: è Mimì che è un diavolo, — borbottò lui.
— Benissimo, caro Federico: e tu lasciami stare.
— Ti lascio stare.
— Cercane un’altra.
— La cercherò!
— Peccato che la zia Assunta Astianese, la zitellona, si sia maritata l’anno corso, col vecchio
cancelliere; potevi prenderla tu.
— Hai ragione: ma scriverò a Teano, a donna Margherita Crocco, per chiederla.
— Chiedile tutte due, Margherita e Vincenzella, con la vigna e i quattrini, in tutto quindicimila ducati e centocinquanta anni.
— Sì, sì, mi conviene.
E si guardarono in cagnesco, Federico tirandosi nervosamente i ricci della zazzera e Mimì battendo il piccolo pugno sulla ringhiera della loggetta. Chiarina li guardava, con una malizia affettuosa negli occhi, tenendo sospeso l’uncinetto e giocando col filo.
Federico avea acceso un sigaro, fumava guardando in aria.
Dietro la persiana, Emma Demartino guardava i due innamorati bizzosi: non così, forse, nel tempo lontano, litigavano dolcissimamente con Carluccio Scoppa? Le mani molli le erano cascate in grembo, smorte sul vestito bruno di lana, e il gomitolo del filo era caduto per terra: il gatto, il vecchio gatto rosso e grasso, arrotolato, sonnacchioso, egoista, non si degnava neppure di scherzare col gomitolo.
— Mimì, — chiamò Federico.
Quella non rispose, scrollando le spalle.
— Non far la capricciosa, Mimì; lo sai che ti voglio bene, — e queste ultime parole le disse
piano, guardandosi intorno.
— Stt! — fece lei, mettendosi un dito sulle labbra, ma con la fisonomia già rasserenata.
— Perchè?
— Ti possono sentire.
— Chi vuoi che senta? Tutti dormono a quest’ora.
— Se mammà viene a sapere che io parlo con te, di qui, ogni giorno, non mi manda più da
Chiarina e mi chiude in camera.
— Per carità, come faremmo?
— Moriremmo, — esclamò tragicamente la biondina.
— Ma che!
— Certo: io sarei capace di buttarmi nel pozzo, come si racconta che facesse Paolina Gasbarra,
per un ufficiale biondo.
— Ma non è morta.
— Non è morta subito, l’anno ripescata ancora viva: ma ha preso una bronchite, è morta tre
anni dopo, di mal sottile. Anche io morirò di tisi, Federico, se non posso sposarti?
— Non dire queste cose, che mi contristi.
E si guardarono con tanta malinconia ed erano così giovani, sani e belli, che Chiarina Oliver
scoppiò a ridere convulsamente.
— Ma perchè la tua mammà è così cattiva?
— Mammà è buona, — rispose la biondina, — ma dice che siamo troppo giovani, che è un
capriccio da ragazzi, che tu non hai serietà, che bisogna aspettare.
— Io ho ventiquattro anni: diventeremo vecchi, ad aspettare.
— Io ne ho sedici: mammà vuol farmi diventare una zitellona.
E non aveva avuto una volta anche lei sedici anni, la donna che ascoltava, senza più lavorare,
dietro la persiana verde? Quando, in che epoca soave e remota della vita? E non avea creduto, allora, che la gioventù non le dovesse mai finire?
— Ci vieni al matrimonio di Maria Orlando? — domandò Mimì.
— Come tu vuoi, Mimì.
— Vieni; Maria Orlando vuol fare una festa grande ora che è arrivata a sotterrare, uno dopo
l’altro, i due mariti, i due fratelli Mosca: ora piglia il terzo, e così tutte le ricchezze di casa Mosca passano in casa Orlando. Vieni: noi ci andremo, la comare Grazia vuole presentarti a mammà, cerca di piacerle, non dirle nulla, ma sta serio.
— Posso far la corte alla comare Grazia? — Nossignore, insolente!
— Allora a tua zia Olimpia, così simpatica? — Niente affatto, signor birbone!
— E che farò? Con chi discorrerò, per non farti arrabbiare? Mi attaccherò alla tua matrina, Mimì: è vecchia abbastanza, non ti pare?
— Zitto! — fece la biondina, guardando la finestra dalla persiana verde.
Ma la matrina non si mosse, non dette segno di vita, non un fremito l’agitò per la crudeltà di quei due innamorati. Non era forse stata felicemente crudele, anche lei, nel tempo, nel passato che era fuggito via, velocemente?
— Che dirò alla mamma tua, per farle piacere, Mimì? — Parlale dei figliuoli: non vuol sentire altro.
— Le parlerò di te: le dirò che ti amo.
— Tu sei matto, Federì: parlale dei maschi.
— A chi vuol più bene?
— Vuol bene a tutti.
— Non è Gaetanino che preferisce?
— No, no, ci ama tutti egualmente. Parlale di Ferdinando che è al collegio militare di Napoli, vi
ha preso la cifra reale, la settimana scorsa, o di Carluccio che è il più bello di tutti….
— Tu sei la più bella….
—…. non m’interrompere. Congratulati per Gaetanino che è guarito così miracolosamente del
vaiuolo, dille che Paolino e Pietruccio sono tanto carini. Insomma, pensa che ella non ha altro pensiero che noi, altro amore che per noi.
— E per papà?
— Le donne, quando hanno i figliuoli, non amano più il marito, — disse solennemente la biondina.
— Anche tu vuoi fare così?
— Anch’io.
— Allora preferisco non aver figliuoli.
— Non ti far sentire dir questo a mammà.
Macchinalmente Emma Demartino avea messo la mano in tasca, ne aveva cavato il rosario e
aveva cominciato a recitarlo, tra sè, per non ascoltare più quella conversazione. Era una preghiera che si staccava monotonamente da quello spirito: una preghiera senza slancio e senza fervore. Ella non aveva più nulla da chiedere, nè per sè, nè per gli altri. Soltanto per un’antica abitudine, a ogni Pater aggiungeva un Requiemi, da che Carluccio Scoppa era morto di cholera a Napoli; e a questa preghiera, che invocava pace al povero morto, seppellito in un cimitero senza fiori, sotto una pietra senza nome, un lieve riflusso malinconico di vita le inondava il cuore. Il povero morto non l’avea amata, no: era rimasto in Napoli, avea sposata una napoletana; lei, Emma, era rimasta zitella, non si sa come, non si sa perchè, — ma ella era ormai senza rancore, piena solo di una grande tristezza, come se tutto si staccasse da lei, un grande funerale lento. Giusto dalla chiesa della Croce un rintocco fievole, a morto giunse.
— Chi è morto? — chiese Mimì.
Emma tese l’orecchio.
— Donna Irene Moscarella, — rispose Federico. — Aveva novant’anni o centoventi, forse.
— Chi piglia il posto, ora?
E maliziosamente, senza parlare, Mimì la bionda, con l’occhio e col gesto sorridendo, indicò il balcone della sua matrina, Emma Demartino.
Emma avea visto tutto: occhiata, cenno, sorriso, — e le erano arrivati al cuore, senza farla trasalire. In verità, ella posava nella suprema inerzia dello spirito: niuna cosa umana poteva darle una speranza o un rimpianto.
Fine.
About author
You might also like
Le dame, i cavallier, l’armi, gli amori. Ecco la Capua medievale
Luigi Fusco – Persistono nella città di Capua diverse testimonianze della stabile presenza o del solo passaggio di alcuni ordini cavallereschi e dei crociati durante l’età medievale. La maggior parte
Caserta. Al Comunale il Salotto a Teatro incontra Sal Da Vinci
Regina Della Torre – Sal Da Vinci sarà l’ospite del terzo appuntamento stagionale del format giornalistico “Il Salotto a Teatro”, ideato e condotto da Maria Beatrice Crisci. L’incontro è per
Orestea di Eschilo, a Giurisprudenza l’analisi della tragedia antica
Redazione -Interessante pomeriggio di riflessione al Dipartimento di Giurisprudenza della Vanvitelli nell’ambito del ciclo “Caffè letterari”. «L’invenzione del processo. Una lettura dell’Orestea di Eschilo», il tema dell’incontro. «Il Dipartimento di